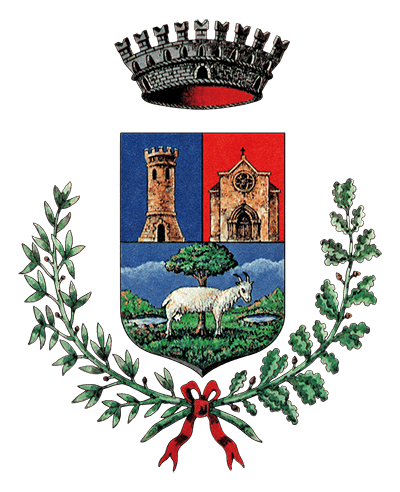Itinerari della devozione popolare

Madonna Ausiliatrice
Nella campagna lo sguardo non incontra più ostacoli. E’ ormai lontano il ricordo visivo delle piantate, della vite maritata all’olmo, dei filari di salici in riva ai fossati, delle siepi, delle alberate rive dei canali, delle fontane naturali pronte a dissetare i contadini al lavoro. La miseria e le tribolazioni di tante famiglie hanno ormai pochi testimoni. Dalle facciate delle ultime case coloniche ci accompagna lo sguardo di silenti e quasi invisibili immagini sacre. Nicchie ormai spoglie, brandelli di colore, sembianze consumate dal tempo, sono i segni che restano dell’antica devozione popolare praticata in questi luoghi.Si tratta in gran parte di raffigurazioni della Madonna col Bambino e di S.Antonio Abate, opera di pittori ed artigiani ambulanti, risalenti al periodo di fine Ottocento, inizi Novecento. Simboli assunti dal mondo contadino a protezione della casa, degli animali, dei raccolti, in sostanza di quel luogo definito ove si svolgeva l’intera esistenza della famiglia, dalla nascita alla morte. Un atteggiamento d’ispirazione pagana, tipico delle società contadine, via, via trasformatosi in quello più ortodosso della devozione religiosa. Una sola maestà a cappella (Secolo XIX) si erge invece sul territorio, all’imbocco di via Casetto, dedicata alla Madonna della Tosse, per molto tempo indicata con il termine di Madonèina (Madonnina), entrato nel gergo toponomastico. Davanti all’immagine devozionale che ritrae, all’interno di nicchia, la madonna con Bambino dal potere taumaturgico di guarire la tòsa catìva (pertosse), si usava recitare il rosario nelle sere di maggio. Per lungo tempo la cappelletta ha pure custodito un ex voto dipinto su tavoletta di legno e risalente al 1856, che raffigura un ragazzo caduto, con carrozza e cavallo, in un canale. La credenza popolare vuole che il fatto sia proprio accaduto in questo luogo.
La maestà, per lungo tempo in condizioni di degrado, è stata restaurata nel 1993 per iniziativa della Signora Anna Beltrami in Montanari, in memoria del marito Nando. L’opera di pulitura e di ripristino del dipinto ha evidenziato i segni del disegno preparatorio, tracciato con uno strumento appuntito sull’intonaco fresco, mentre dalla resistenza del colore residuo, si è potuto valutare che il dipinto medesimo fosse stato eseguito su intonaco ancora umido, secondo la tecnica antica dell’affresco. Ad ulteriore testimonianza dell’antica devozione popolare dei nostri contadini è da segnalare la presenza di diversi oratori, quello di San Rocco preesistente l’attuale chiesa di Caprara, indissolubilmente legati alle pratiche religiose delle comunità contadine di Valle Re, e quello del Gualtirolo. (testo di Giovanni Cagnolati)